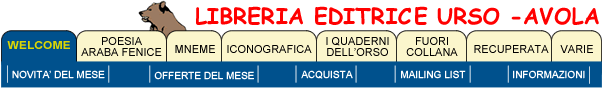
COME INTERPRETARE IL TEMPO?
Da alcune settimane si è posta la domanda inaugurante il nostro giardino
zen virtuale, e ho cercato in librerie e bancarelle dell’usato autori –
amici che potessero stimolare una risposta ampia ed espressiva. Infine ho preferito
ascoltare il ricordo delle letture ed esperienze già depositate e sedimentate,
e dall’insieme originare qualche riflessione.
Chi pone la domanda come interpretare il tempo?
E’ la MENTE – centro labirintico e misterioso delle associazioni e
dei pensieri - che utilizza il proprio linguaggio per interrogarsi su se stessa.
Le caratteristiche della mente, almeno nella nostra domanda, credo siano analitiche
(come), valutative nel vedere la realtà con qualche filtro selettivo
(interpretare), e divisorie in quanto il tempo si classifica in passato, presente,
futuro.
Difatti quando pensiamo al tempo, mille ricordi ci visitano: l’infanzia,
i familiari, gli anni di scuola, gli amori, i lavori, i viaggi, le storie vissute,
i Maestri incontrati, le letture, i grandi dolori e le gioie, la ricerca, gli
amici… E c’interroghiamo sul dove sono gli affetti e le voci e le
presenze scomparse fisicamente, e qual è il vero senso del tempo che
passa?
Una volta Osho, il gran maestro spirituale, disse che la vita non è un
mistero da capire ma da vivere. Questa chiave di riflessione mi accompagna spesso
ma pur rimane la domanda; sicuramente la non permanenza di noi nel Tempo ci
angoscia in profondità, e la quotidianità del lavoro e dei linguaggi
del mondo servono forse a distrarci da questa paura inconscia.
Ho altri saggi che mi consolano dalle leggi del Tempo: Krishnamurti molti anni
fa c’insegnò a vedere e ascoltare senza interpretare, e imparare
senza accumulare, in modo che si sia sempre freschi, sorpresi, incantati e vivi
come si è da piccoli; ripetendo, e applicando seppur non sempre con costanza,
la frase non solo buddista d’essere presente al Respiro presente, nel ricordo
di Sé; e anche l’evitare di progettare troppo perché ci si
dimentica della propria vita interiore in armonia con il ritmo del soffio universale
appagante (a Thay devo questo recente consiglio) …Thay, disse inoltre,
qualcosa che mi colpì, una vera scossa di quei blocchi mentali e culturali
che sono programmati sin da piccoli, e che sono funzionali all’ordine del
Tempo basato sul dominio e strategia di controllo della natura e sui viventi;
Thay disse, invertendo l’ordine cartesiano, SE NON PENSO SONO. Cosa intendeva
dire?
L’affermazione planetaria del primato dei pensieri e delle mille associazioni
mentali è una caratteristica dell’uomo moderno.
Ma l’intelligenza più vicina alla propria essenza non è del
pensiero ma del cuore, così ci tramandano gli antichi: il cuore è
il vero centro di confluenza delle emozioni e dei pensieri; l’intelligenza
del cuore comprende anche quella funzionale della mente, un po’ come il
sole che illumina e irraggia la luna all’alba.
In molte scuole iniziatiche s’afferma che i tre centri fisico – emozionale
– intellettuale non sono così distanti e scollegati, tant’è
che è nell’esperienza di tutti il riscontro che una sofferenza mentale
si ripercuote sul fisico e sul sentimento. L’armonia dei tre centri è
essenziale, ci ricorda il maestro armeno George Ivanovitch Gurdjieff.
Quando vi è – raramente - armonia, si è in un certo qual
modo fuori delle leggi vincolanti del tempo, si è testimoni del Non –
Tempo, raggio di sole dell’esistenza.
La domanda sul tempo è espressa dal centro da cui si generano associazioni,
riflessioni ma che pur rimane una parte dell’umano.
Uno scompenso di un centro sull’altro genera una disfunzione a noi dannosa.
Occorre dunque sempre equilibrarli tutti, in modo che le emozioni, il corpo
e il centro intellettuale cooperino nell’equilibrio; un intellettuale dovrebbe
magari impegnarsi anche in un lavoro fisico quando il carico dei pensieri è
eccessivo, e lo stesso vale per chi si sbilancia in altri centri: chi è
troppo emotivo si equilibrerà con la parte riflessiva, e allo stesso
modo chi è trascinato dagli istinti assorbenti del corpo.
Una volta equilibrati i centri tra loro connessi e ben stratificati,
- la carrozza corporale è nutrita, funzionante e ben guidata; i sentimenti
e le emozioni non sono più cavalli in fuga disordinata; il cocchiere
è ben istruito, creativo, libero dalle gabbie dei pensieri secondari;
- si esce dalla ruota ciclica dei corsi e ricorsi, dalla meccanicità
dei pensieri e si aspira ad altri sentieri umani.
Ciccio
nella nostra panchina zen per intuito e magia del Caso si chiede: quali sono
i sentieri dell’uomo?
Rochan
PS. Dopo aver letto queste brevi riflessioni si consigliano:
una passeggiata camminando presenti e consapevoli del contatto dei propri passi
con la terra, prepararsi un buon caffè e sorseggiarlo con attenzione,
sgombrare la mente dalla lettura fatta. Il tutto con giocosità…
Spiegare il tempo, darne una definizione? Il tempo è stato definito “la
distanza fra due eventi”. Ma la nostra esperienza sembra dirci che il tempo
non dipende dagli eventi; sembra che proceda sia che una cosa avvenga o no.
Quindi, il tempo scorre, a prescindere? Il poeta inglese Austin Dobson nel 1877
disse: “Il tempo passa, dite voi? Il tempo resta: a passare siamo noi!”
Dobson morì nel 1921, quasi 80 anni fa. Il tempo è andato avanti.
Ma dove ebbe inizio il tempo, e dove va?
La Bibbia non dà nessuna definizione del tempo, il che fa pensare che
forse è qualcosa che supera la comprensione umana. È come l’estensione
infinita dello spazio, concetto che pure abbiamo difficoltà ad afferrare.
A quanto pare il tempo è una di quelle cose che solo Dio può capire
pienamente, in quanto solo lui è “da tempo indefinito fino a tempo
indefinito”(Salmo 90:2)
Comunque, il tempo ha certe caratteristiche che si possono comprendere. L’apparente
velocità con la quale trascorre può essere misurata. Inoltre esso
è unidirezionale, si muove in una sola direzione. Come il traffico in
una via a senso unico, il tempo trascorre inesorabilmente in quell’unica
direzione, in avanti, sempre in avanti. Qualunque sia la velocità del
suo movimento in avanti, non lo si può mai far retrocedere. Viviamo in
un presente momentaneo. Comunque, questo presente è in movimento e scorre
di continuo verso il passato. Non si arresta.
Il passato è trascorso, è storia e non si può più
ripetere. Qualsiasi tentativo di richiamare il passato è impossibile
come quello di far risalire l’acqua di una cascata o di far tornare una
freccia all’arco che l’ha scoccata. Quante volte voltandoci ad osservare
le impronte che abbiamo lasciato nelle sabbie del tempo, abbiamo pensato: “Se
solo potessi tornare indietro…” I nostri errori lasciano la loro traccia
nel fluire del tempo e in modo simile, le opere buone compiute da un uomo in
passato lasciano un orma, un calco che non può essere cancellato.
Il futuro è diverso. Scorre sempre verso di noi. E se è vero che
oggi noi siamo quello che ieri abbiamo deciso di essere, le nostre decisioni
di oggi possono modellare il nostro domani, il nostro futuro, e dargli un indirizzo
diverso.
Anche se la Bibbia non definisce il tempo, ne parla come di una realtà.
Tanto per cominciare ci dice che Dio creò i “luminari” —
il sole, la luna e le stelle — come indicatori del tempo, perché
servissero “come segni e per le stagioni e per i giorni e gli anni”.
Molti avvenimenti riportati nella Bibbia sono fermamente collocati nel corso
del tempo. E nelle Sacre Scritture esistono espressioni che ci dimostrano come
il tempo fosse diviso in maniera simile ai nostri giorni: vediamone alcune.
La parola “giorno” è usata nella Bibbia con parecchi significati
diversi, così come anche oggi ha molte accezioni. La terra, compiendo
una rotazione completa sul proprio asse, misura un giorno di 24 ore. In questo
senso un giorno consta di un periodo diurno e uno notturno, per un totale di
24 ore. (Giovanni 20:19) Comunque, il periodo di luce del giorno stesso,
di circa 12 ore, è pure chiamato giorno. “E Dio chiamava la luce
Giorno, ma chiamò le tenebre Notte”. (Genesi 1:5) C’è
quindi anche la parola notte, indicante il periodo approssimativo di 12 ore
di oscurità. (Esodo 10:13) Un altro significato si ha quando per
“giorni” si intende il periodo in cui visse qualche personaggio notevole.
Per esempio, i giorni di Noè e Lot sono menzionati per la loro importanza
profetica. (Luca 17:26-30) Un altro esempio dell’uso della parola
“giorno” in senso ampio o figurato è dato dall’affermazione
di Pietro secondo cui “un giorno è presso Dio come mille anni”.
(2 Pietro 3:8) Nel racconto di Genesi un giorno creativo è un
periodo di tempo ancora più lungo, della durata di millenni. (Genesi
2:2,3 ) Il contesto biblico permette di capire in che senso si deve intendere
la parola “giorno”.
La divisione del giorno in 24 ore viene attribuita agli egiziani. L’attuale
divisione dell’ora in 60 minuti si deve ai babilonesi, che seguivano un
sistema di calcolo sessagesimale. Nelle Scritture Ebraiche (o Vecchio Testamento)
non si fa menzione di una divisione del tempo in ore. Invece di dividere il
giorno in ore specifiche, le Scritture Ebraiche indicano il tempo mediante espressioni
come “mattina”, “mezzogiorno” e “sera”. (Genesi
24:11; 43:16; 1 Re 18:26) La notte era divisa in tre periodi chiamati “veglie
della notte” (Salmo 63:6), due delle quali sono specificamente nominate
nella Bibbia: la “veglia intermedia della notte” (Giudici 7:19)
e la “veglia del mattino”. (1 Samuele 11:11)
La Bibbia parla di “mesi lunari”. (Esdra 6:15) I nostri mesi
attuali non sono mesi lunari, perché non sono determinati dalla luna.
Sono semplicemente 12 divisioni arbitrarie dell’anno solare. Il mese lunare
è determinato dalla luna nuova. Le fasi della luna sono quattro e formano
una lunazione di 29 giorni, 12 ore e 44 minuti. Basta guardare la forma della
luna per sapere approssimativamente che giorno del mese lunare è.
Secondo l’antico computo biblico, l’anno andava da autunno ad autunno.
Ciò era particolarmente adatto alla vita agricola, poiché l’anno
cominciava con l’aratura e la semina verso la prima parte del nostro mese
di ottobre e finiva con la raccolta. Noè contava l’anno a cominciare
dall’autunno. Egli riferì che il Diluvio era iniziato “nel
secondo mese”, che corrisponderebbe alla seconda metà di ottobre
e alla prima metà di novembre. (Genesi 7:11) Ancora oggi presso
molti popoli della terra l’anno nuovo comincia in autunno. Al tempo dell’esodo
dall’Egitto, nel 1513 a.E.V., Geova decretò che abib (o nisan, corrispondente
circa all’attuale periodo marzo/aprile) divenisse per gli ebrei “il
principio dei mesi”, così che da allora ebbero un anno sacro, che
andava da primavera a primavera. (Esodo 12:2) Comunque, oggi gli ebrei
seguono un anno secolare, o civile, che comincia in autunno, con tishri (settembre/ottobre)
come primo mese.
Per indicare l’ora, gli ebrei usavano espressioni colorite e interessanti.
Queste espressioni idiomatiche non solo danno un’idea dell’ambiente
e dei costumi locali, ma rivelano anche qualche aspetto delle circostanze nelle
quali avvenne un determinato fatto.
Ad esempio, Genesi 3:8 dice che fu “verso l’ora del giorno
in cui soffia la brezza” che Dio parlò ad Adamo ed Eva il giorno
che essi peccarono. Doveva essere più o meno l’ora del tramonto,
quando si levavano fresche brezze che recavano sollievo dalla calura del giorno.
D’altra parte, Genesi 18:1, 2 mostra che gli angeli di Dio vennero
alla tenda di Abraamo a Mamre “verso il caldo del giorno”. Immaginando
il sole di mezzogiorno a picco sulle colline della Giudea, la calura poteva
essere opprimente. Quella in genere era l’ora in cui mangiare e riposarsi.
Pertanto, Abraamo “sedeva all’ingresso della tenda”, dove poteva
esserci una leggera corrente d’aria, forse concedendosi un momento di riposo
dopo aver mangiato. Possiamo apprezzare ancora di più l’ospitalità
di questo uomo anziano quando leggiamo che si mise a ‘correre incontro’
ai visitatori, che poi ‘andò in fretta alla tenda’ per dire
alla moglie Sara di preparare il pane, che ‘corse alla mandria’ e
che ‘andò in fretta a preparare’ un toro. Tutto questo sotto
il sole di mezzogiorno! (Genesi 18:2-8)
Gli ebrei dividevano evidentemente la notte in tre periodi detti “veglie”.
Ciascuna veglia durava un terzo del tempo compreso fra il tramonto e l’alba,
cioè circa quattro ore, a seconda della stagione. (Salmo 63:6)
Fu “all’inizio della veglia intermedia della notte”, che andava
più o meno dalle 22 alle 2 del mattino, che Gedeone, comandante dell’esercito
israelita, sferrò il suo attacco contro l’accampamento madianita.
Un attacco a quell’ora chiaramente colse di sorpresa le sentinelle.
Al tempo dell’Esodo, Dio fece “ritirare il mare mediante un forte
vento orientale durante tutta la notte”, permettendo agli israeliti di
attraversare il mare sull’asciutto. Quando gli egiziani stavano per raggiungerli
era già “la veglia del mattino”, e Dio mise in confusione il
campo degli egiziani e alla fine li distrusse facendo tornare il mare “alla
sua condizione normale sul far del mattino”. (Esodo 14:21-27) Ci
volle quindi quasi una notte intera perché il mare si dividesse e gli
israeliti lo attraversassero.
Nel I secolo gli ebrei avevano adottato la suddivisione del giorno in dodici
ore. Ecco perché in una delle sue illustrazioni Gesù disse: “Ci
sono dodici ore di luce nel giorno, non è vero?” (Giovanni 11:9)
Queste ore si contavano dall’alba al tramonto, cioè pressappoco
dalle 6 del mattino alle 18. Pertanto, “la terza ora” equivarrebbe
più o meno alle 9 del mattino. Era questa l’ora in cui, il giorno
di Pentecoste, fu versato lo spirito santo. Quando i discepoli furono accusati
di essere “pieni di vino dolce”, Pietro respinse subito tale accusa,
ed era oggettivamente difficile pensare che, a tale ora, 120 persone potessero
essere già tutte ubriache.
Al tempo della dominazione romana, sembra che gli ebrei avessero adottato la
suddivisione greca e romana della notte in quattro veglie (o vigilie) invece
delle precedenti tre. In Marco 13:35 Gesù evidentemente alludeva
a tale suddivisione. La veglia “sul tardi” andava dal tramonto fino
alle 21 circa. La seconda veglia, quella di “mezzanotte”, iniziava
verso le 21 e terminava a mezzanotte. Il “canto del gallo” andava
da mezzanotte fin verso le 3 del mattino. E l’ultima veglia, quella della
“mattina di buon’ora”, terminava all’alba, cioè verso
le sei.
Nella Bibbia l’espressione tempo ricorre più di 1.200 volte: spesso,
come abbiamo visto, per esprimere e cercare di definirne lo scorrere, altre
volte con significato profetico (“un tempo, dei tempi e la metà
di un tempo”in Daniele 7:25). Ritroviamo infatti riferimenti al “tempo
della fine” (Daniele 12:4), ai “tempi fissati delle nazioni”
(Luca 21:24), agli “ultimi giorni” (2 Timoteo 3:1).
In altre occasioni, compare l’idea di tempo indefinito, di eternità:
il termine ebraico `ohlàm esprime l’idea di tempo indefinito
o incerto. Un lessicografo lo definisce “tempo nascosto, cioè oscuro
e lungo, di cui è incerto o indefinito il principio o la fine”.
(W. Gesenius, A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, trad.
inglese di E. Robinson, 1836, p. 746) Altri termini ebraici simili sono `adh,
che indica un futuro illimitato, qualcosa che sta per sempre o è eterno.
(Abacuc 3:6) e nètsach, che può indicare eternità. Nelle
Scritture Greche Cristiane (o Nuovo Testamento) il termine aiòn può
indicare un periodo di tempo di durata indefinita o indeterminata, un periodo
di tempo remoto, ma non infinito.
E su questa idea di eternità, su questo desiderio innato nell’essere
umano potremmo aprire un altro capitolo del tema “tempo”. Anche se
tutti gli esseri viventi tendono ad aggrapparsi alla vita, sembra che solo l’uomo
abbia il concetto del tempo: passato, presente e futuro. . Il neurofisiologo
William H. Calvin osserva: “A parte i preparativi per l’inverno e
per l’accoppiamento, che sono stimolati da ormoni, gli animali manifestano
una scarsissima propensione alla pianificazione su tempi che superino qualche
minuto”. Gli animali possono mettere da parte del cibo prima della stagione
fredda, ma non fanno ragionamenti e progetti. L’uomo può meditare
sul passato e attendere il futuro, facendo dei piani per esso, addirittura desiderando
ardentemente di esserci. E può provare frustrazione quando non riesce
a realizzare i suoi sogni per il futuro a motivo della natura limitata della
sua breve vita.
A questo proposito, la Bibbia dice “Anche il tempo indefinito [il Creatore]
ha posto nel loro cuore”. La versione della CEI traduce così questo
versetto: “Ha messo la nozione dell’eternità nel loro cuore”,
mentre The New English Bible : “Ha dato agli uomini il senso del passato
e del futuro”.(Ecclesiaste [Qoelet] 3:11) Noi usiamo questa capacità
caratteristica ogni giorno, anche nei gesti più semplici, come quando
ci guardiamo allo specchio e pensiamo a come saremo tra 10 o 20 anni. E confermiamo
le parole di Ecclesiaste 3:11 quando riflettiamo anche per un momento
su concetti come l’infinità del tempo e dello spazio. Il semplice
fatto che abbiamo questa capacità è in armonia con l’affermazione
secondo cui un Creatore ha “messo la nozione dell’eternità”
nel cuore dell’uomo.
Tale nozione, tale senso del futuro, tale desiderio di eternità è
sempre stato oggetto di meditazione e di analisi da parte dell’uomo: basti
pensare alla ricerca degli imperatori cinesi e dei sacerdoti taoisti dell’elisir
di lunga vita, della fonte dell’eterna giovinezza, alle sospensioni croniche,
alle innumerevoli dottrine diffuse in quasi tutte le religioni su una possibile
vita dopo la morte. Ma questa è un’altra storia, forse.
Andrea Cavaliere
Che
bisogno ha un poeta
di tempo e di economie
per cantare, amare, e nuotare
in un Mediterraneo di sogni?
Carissimi
Dioscuri del Giardino Zen
Finalmente sono riuscito ad entrare nel “ server momentaneamente occupato”
e mi son fatta una bella cavalcata a ritroso nel “tempo” addomesticato
dalla retorica del valore e del plusvalore. Devo ammettere che è una
bella pagina, cortesemente sapienziale, odorosa di biblioteche, che sono i miei
spazi dell’anima soprattutto se all’interno di un’agora vegetale,
con odore di fiori di mandorlo. Grazie Carmelo, forse un giorno avremo l’occasione,
estremamente improbabile, di incontrarci e chiaccherare in consapevolezza dei
terrori e degli orrori che questa “scienza” ha generato nella storia
della società umana. Dietro i bombardamenti a tappeto di Bagdad, ci sta
l’economia; dietro lo stato di fame del 50% della popolazione terrestre
ci sta l’economia; dietro la mancanza di acqua per tre miliardi di persone,
ci sta l’economia; dietro la violenza come mezzo di contrattazione sociale,
ci sta l’economia; dietro le sante crociate che santificarono il genocidio,
ci sta l’economia; dietro l’invasione piemontese e susseguente annessione
predatoria, ci sta l’economia. No, grazie.
Tempo, tempi, se ne avessimo il tempo sembra cantare la Liliana della fotografia.
[Liliana] La chitarra è “tempo”, la musica è “tempo”;
quando diciamo tempo/illusione diciamo fenomeno/illusione ed ammettiamo quindi
sillogisticamente che il tempo è un fenomeno, non soltanto in Husserl
o nel pensiero Yogacara ma anche in economia. L’osservazione sul comportamentalismo
è pertinente, vale anche in psicologia, in ecologia applicata, vale nella
dinamica delle relazioni; c’è anche una sociologia del tempo.
Il tempo fu mito, non solo nel Cronos dei Greci, ma prima ancora nei Sumeri
e forse, ma non ne abbiamo le prove, prima dei Mesopotamici. Il tempo fu caro
ninnolo a verseggiatori di epoche non contabili, fonte di tristezza al dilapidarsi
di vellutate epidermidi o all’inevitabilità di scendere un paio
di metri sotto i piedi. Deità e mortali dialogarono in lingue diverse,
i linguaggi dello spirito e del contorsionismo carnale, i linguaggi del gioco
e quelli della danza, sulla fenomenologia incompresa del tempo. L’incomprensione
li dannò al dolore nonostante Shiva sembri profondamente immerso nel
cerchio della sua lila creativa, ma quella del dio Hindu è una danza
immobile, non ha memoria di tempo né consistenza nel tempo.
L’epica omerica è l’epica del tempo, il tempo della morte vissuta
come sacrificio ineluttabile in Achille, il tempo del dubbio e dell’inganno
nell’incavo del cavallo, il tempo della umana desolazione nel vagabongaggio
di Ulisse.
Insomma, il tempo come metaforico filo di Arianna che però non conduce
fuori dal giardino di Dedalo.
Il tempo fu l’espiazione catartica del diluvio nel testo ebraico, in quelli
sumeri e babilonesi, presso i mesoamericani, gli asiatici, e dell’entropia
della coscienza umana da Buchenwald alle Twin Towers. Il recente massacro di
Gerusalemme ha scardinato tutte le mie annotazioni di impegni e ho dimenticato
la necessità di telefonare a qualcuno in Israele, il tempo mi è
esploso nelle mani, ho sentito il kamikaze palestinese piangere di rabbia sulla
follia del suo gesto ma era già diventato un filo d’erba. Il dolore
degli altri fatica a scivolare nell’esiguo condotto di una clessidra continuamente
capovolta, dagli Assiri a Tito, quello di cui parla Tacito, ne fecero un deserto
e lo chiamarono pace, dal decreto dei cattolicissimi reali di Spagna e di Sicilia
ad Auschwitz, e molti fiumi traversando.
Per Einstein fu una dimensione della realtà fisica; per coloro che non
varcano ancora la soglia della dualità nascita-morte verso la non-nascita/non-morte,
il tempo è un elemento nello studio della patologia comportamentale.
Per molti il tempo è la dimensione in cui gli eventi, fattuali o ipotizzati,
accadono; quindi anche i sogni, le speranze, i desideri. Il tempo non esiste
indipendentemente dagli avvenimenti che accadono nel tempo, ci tramandano Liebnitz
e, prima di lui, Aristotele. Ma gli avvenimenti sono fenomeni, quindi -in quanto
privi di identità propria indipendente- illusori. Ma se i fenomeni sono
illusori, e lo sono, eccoci indietro al paripatetico sillogismo: il tempo è
illusione.
Mi sembra evidente, nella trama di queste varianti, che il tempo è l’inventore
della schiavitù. Lo abbiamo inventato e gli ci siamo sottomessi.
Recenti scoperte cosmologiche hanno scoperto la “prima” luce, la prima
galassia, ma perché “prima”? Ci danno la data esatta della
nascita dell’universo, non quella del buon seicentesco vescovo di Oxford
che ne fissava anche l’ora, ma 13 miliardi e settecento milioni di anni.
Credo che gli scenziati, sazi di barocche ipotesi, si divertano a giocare a
tressette con le stelle. E a dare corpo a un fantasma che non ha, come tutto
il resto, né passato né futuro.
In una struttura economica basata sulla competizione il tempo, nell’accezione
relativa, determina il costo finale di un bene ma non ne inficia il valore intrinseco.
Per le carovane del sale o della seta il tempo era un agente di assimilazioni
culturali, pressocché privo di valore economico.
Nella catena di distribuzione dei beni deperibili il tempo può distruggere
il valore commerciale dell’oggetto in vendita, diventa causa di perdita
o di profitto; ma questa sarebbe una analisi superficiale perché non
è il tempo ma il potenziale consumatore che alla fine firma il bilancio.
Se l’acquirente compra –poco conta se poi sonsuma, almeno nell’immediato-
il bene mantiene il valore attribuitogli, se l’acquisto non viene effettuato
il bene non è più un bene ma un oggetto da riciclare.
In questo momento l’economia, per quel che mi riguarda, è soltanto
un supporto teorico, relativamente necessario, alla giusta distribuzione delle
risorse. Il resto -con il massimo rispetto per i vecchi Keynes, Modigliani e
anche per Fukuyama- ketchup philosophy.
A meno che non vogliamo parlare di “trasformazione dell’economia”,
cioè di quel processo già in atto negli Stati Uniti d’America
e, parzialmente, in Europa che mette insieme produttori, distributori e consumatori.
Si tratta di gruppi “economici” ove ciascuno, a livello individuale,
è equanimamente responsabile. Gruppi il cui scopo motivante è
quello di assicurare una produzione di qualità, rispettare l’ambiente,
garantire un lavoro stabile e un reddito adeguato. All’origine di questi
gruppi c’è una nuova filosofia della responsabilità collettiva,
nulla a che vedere con le vecchie, falsamente romantiche e falsamente egualitarie
cooperative che furono sempre centri di potere o utili supporti a partiti politici.
Su questa linea lavorano non solo neo-economisti ma anche sociologi, ecologi,
poeti e antropologi. Il nuovo protgonista non è più il profitto
ma l’essere umano nella sua sana espresione di libertà e capacità
decisionale.
Esattamente il contrario dell’economia globale, dell’economia americana
che è economia di guerra, di quella economia che David C. Korten chiama
suicide economy.
In situazioni di questo tipo il concetto del tempo come fattore di costo appartiene
a visioni obsolete. E’ anche l’argomento Zen , per quanto lo Zen si
possa interessare di economia: libertà dal bisogno, anche nel senso marxiano,
in un contesto generale e illimitato, nel rispetto delle regole sociali universalmente
accettate, di libertà.
Se scrivo ancora alcune righe sul tempo è perché l’intervento
di Carmelo Pisasale è davvero stimolante. Avrei preferito divagare su
una meditazione camminata nel giardino, lo farò; al mio ritorno da Parigi
e da Marsiglia, sarà la mia prossima lettera.
Ogni qualvolta che mi imbatto in teorie economiche ho la sensazione di trovarmi,
quasi asfissiato, all’interno di un cerchio chiuso dove il tempo si materializza
sempre di più man mano che la sofferenza della claustrofobia aumenta.
Finito lo stress, svanito il tempo del dolore.
C’è un’immagine, quella del serpente che si tiene in bocca
la coda, e non la mangia come usualmente si dipinge, che è un cerchio
sigillato dove il tempo gioca il ruolo di forza costrittrice. Dal cerchio del
serpente non si esce, non si sfugge. All’opposto, il cerchio Zen è
aperto, è una dimensione libera.
Cari amici che bisogno ha un poeta di tempo e di economie per cantare, amare,
e nuotare in un Mediterraneo di sogni?
Sempre vostro
Chan Phap Y
L'economia classica esamina la variabile “tempo” dal punto di vista del consumatore quando analizza lo scambio tra “consumo presente” e “consumo futuro” da parte di un soggetto
 Liliana Calabrese Urso all'incontro di "Avola in Laboratorio" in pizzeria del 29/05/2003 su "Tempo, tempi, se ne avessimo il tempo". |
perfettamente
razionale ma tende a non considerarla come un bene, ma come un elemento –
il tasso d’interesse - la cui rinuncia immediata permette un maggiore
benessere futuro; viceversa quando si esamina il tempo dal punto di vista dello
scambio tra lavoro e tempo libero si tende a non considerarlo come un bene particolare
ma lo si considera come un bene come tutti gli altri.
Certo
il tempo come bene non è
facilmente definibile, in quanto viene sempre utilizzato nell’uso di
un altro bene ed anche nella decisione di acquistare qualsiasi bene e dunque fa da premessa all’utilizzo stesso di
un bene e lo segue da quando ne viene deciso l’acquisto fino a quando
ne termina il consumo: accompagna qualsiasi “comportamento economico”
[1]
. Tuttavia è un “bene”: “nel significato
economico, il termine designa qualunque mezzo considerato idoneo a soddisfare
bisogni”
[2]
; il tempo soddisfa, innanzitutto un bisogno essenziale:
il bisogno di vivere; esso, dunque, deve essere trattato al meglio, deve venire
economizzato. Ma attenzione il tempo è un bene particolare in quanto
è l’unico bene non riproducibile.
Tutti gli altri beni sono riproducibili, che siano scarsi o meno, ad esempio
l’aria e l’acqua si riproducono mediante processi fisici. Lo spazio
si riproduce sia come spazio per abitazioni - si pensi ai grattaceli sempre
più alti – sia come luogo di coltivazione – si pensi alla
resa sempre maggiore delle terre coltivabili -. Ma il tempo perduto non viene
più recuperato è passato e non può più essere
ripreso. Il consumatore razionale non può dunque che considerare il
bene “tempo”, in modo particolare.
Se la mia affermazione
è corretta ne consegue che il tempo non può venire considerato
dalla teoria della domanda come un bene qualsiasi e quindi il consumatore
razionale deve inserirlo nella stessa funzione di domanda. L’individuo
razionale non è quell’essere “buffo” che la teoria
classica ci ha tramandato, che ragiona anche sulla più piccola variazione
di prezzo per deciderne l’acquisto senza considerare il tempo che “perde”,
nell’effettuare un’operazione del genere; individui di tal fatta
esistono e non sembrano razionali. Viceversa un individuo che per certi livelli
di prezzo non opera criteri di valutazione meramente materiali è sicuramente
un individuo razionale. Un individuo che “non perde tempo” nel
decidere un acquisto, di poco valore, è un individuo razionale anche
se spende di più rispetto ad uno che ha perso del tempo nella decisione.
Da una parte ha speso di più dall’altra ha guadagnato più
tempo, che potrà poi meglio impiegare per un’altra decisione
economica o nel consumo di un bene.
Abbiamo
sopra parlato di “perdita di tempo”, riguardo alla decisione di effettuare acquisti di poco valore,
questa espressione non va vista in termini valutativi ma come una componente
comportamentale
[3]
di un individuo che opera in un mondo complesso
[4]
in un arco di tempo breve
[5]
, dove la valutazione materiale del bene non è la sola valutazione ad essere presa in considerazione
[6]
, ma vi sono presenti, al limite altre componenti come quelle riguardanti il rapporto con il soggetto
presso il quale viene effettuato l’acquisto. Eppure questi dati non
sono presi in considerazione dall’economia classica che, di conseguenza, tende a non fare la distinzione tra acquisti
di beni di “poco valore” materiale ed acquisti di beni di “alto
valore” materiale, lega ambedue i tipi di acquisto al prezzo e non tiene
conto della variabile tempo che conseguentemente nel primo caso deve venire
risparmiata e nel secondo deve essere utilizzata al meglio.
Dobbiamo
cambiare, allora, la funzione di domanda introducendo la variabile tempo
Qd =[
f (p)]t
posto
1/nn-->∞
< = t =< 1
f = funzione
inversa
avremo per
pà 0
tà 1/nn-->∞
Qd=[ f (p)] 1/t.
pà∞
tà1
e quindi
Qd=[ f (p)]
t = 1
da cui, in
ambedue i casi
p=(Qd)t/f.
Ossia per
l’individuo razionale, la
quantità domandata è funzione del prezzo solo “attraverso”
il tempo. Più basso è il prezzo, minore è il tempo impiegato
per decidere l’acquisto, si dovrà elevare la funzione per un valore più piccolo, e dunque meno vale la relazione prezzo/quantità;
più alto è il prezzo, più lungo il tempo impiegato per
decidere l’acquisto, più
vale la relazione prezzo/quantità,
più si dovrà elevare la funzione ad un valore prossimo ad 1. Perché
è proprio il tempo che ogni individuo razionale deve risparmiare in
quanto è l’unica risorsa non solo scarsa ma anche irriproducibile.
Trovo nel manuale di
Samuelson
[7]
: “Gary Becker dell’Università di Chicago,
ha osservato che economizzare il tempo
è una cosa che riguarda ognuno di noi: < Se siamo in pensione
e di pensione prendiamo poco, dedicheremo molto tempo alle compere
in cerca di buone occasioni, troveremo razionale acquistare cibi non preparati,
utilizzando il nostro tempo libero (che non ci costa niente) per prepararli
noi stessi. Se invece siamo una donna che lavora e ha un buon stipendio,
razionalmente risparmieremo tempo, facendo compere in qualche negozio
costoso con tanti commessi, ordineremo quello
che ci serve per telefono, che ce lo portino a casa, e pagheremo per questo servizio speciale…e tutto
questo non lo faremo perché non sappiamo far bene i nostri conti, ma
anzi a ragion veduta, perché a conti fatti ci conviene. Il lettore
può elencare innumerevoli esempi analoghi di ripartizione razionale
del tempo: per esempio l’uso di congegni razionali in un epoca in cui
il personale è scarso e costoso
>. Queste non sono escursioni
fuori dal campo dell’economia tradizionale. Sono alcune fra le
applicazioni che si sarebbero dovute fare da un pezzo, delle scelte economiche
a settori tradizionali non trattati dall’economia”. L’analisi
di Becker conferma la mia affermazione che il tempo va posto in relazione
diretta al prezzo, difatti quella che analizza Becker non è la relazione
tra quantità domandata e prezzo ma tra quantità domandata e reddito
in questa relazione a differenza della relazione domanda/prezzo vale la relazione
diretta, e, quindi, dovrà valere la relazione temporale inversa: “reddito
più alto/tempo più breve”. Ma non è logico che
chi dispone di redditi più alti preferisca impiegare il tempo a lavorare
e guadagnare più soldi di quelli che spende? E non vale il contrario
per chi ha un basso reddito e molto tempo?
> Allora per
>
>
rà∞
>
t < 1
>f = funzione diretta
>
>dove r=reddito
>avremo
>
>
Qd = [ f(r)]1/t.
>
>
>
rà0
>
t à 1
>f
= funzione diretta
>
>avremo
>
>
Qd = [ f(r)]t=1.
>
>
>2. La scelta della variabile tempo è stata effettuata
sulla scorta della teoria del moto browniano. Sappiamo che in un determinato
tempo percorriamo tra due punti linearmente un determinato spazio;
qualora viceversa tra gli stessi due punti effettuiamo un percorso non lineare,
il tempo aumenta
[8]
. Così dato un certo rapporto fissato da una costante
inversa, tra domanda e prezzo, affinché il prezzo eserciti sulla domanda
una qualche funzione, il tempo deve essere “lungo”. Viceversa
più è “breve” il tempo più tende ad azzerarsi
il valore della costante
[9]
, e quindi il consumatore razionale può far entrare
in gioco altre variabili, una possibile variabile è quella “imitativa”,
il consumatore imita per l’acquisto di beni di poco prezzo il comportamento
di altri soggetti. In un certo senso è l’inverso del principio
del moto browniano, in questo caso il percorso lineare tra due punti si
lega ad un tempo breve, mentre nel caso della quantità domandata e
del prezzo la relazione lineare si
lega ad un “tempo lungo”.
> Risulta così
paradossalmente razionale una scelta di tipo emozionale: “ Le emozioni…sono oggi interpretate in
termini di <scorciatoia comportamentale> inserita evolutivamente nel
patrimonio genetico per risparmiare tempo e fatica nel reagire a stimoli
situazioni”
[10]
. Nell’utilizzo delle informazioni abbiamo dunque
una “variabile comportamentale emotiva” che inserisce il flusso
di informazioni non solo in un quadro di valutazione razionale costi/benefici,
ma registrandole emotivamente sul comportamento di altri soggetti,
che fanno da capofila ed il cui comportamento è ritenuto affidabile.
Più in generale possiamo dire che è la scelta emotiva basata sul comportamento di altri soggetti
è per prezzi bassi più razionale del criterio costi/benefici;
davanti a prezzi alti e ad acquisti più impegnativi riprende il suo
posto la scelta basata sul rapporto costi/benefici.
>
>
>
>3. Riporto
alla fine una breve nota su tempo ed economia nell’esperienza sovietica.
Nel mondo delle economie dirigiste il valore di un bene veniva, per i consumatori,
calcolato in relazione alla fila che occorreva fare per acquistarlo, quindi
del tempo che occorreva spendere per acquisirlo, essendo il prezzo di un bene,
in genere, ridicolmente basso. Il che implicava che qualora la fila veniva
fatta da coloro che producevano il bene, alla fatica per l’acquisto
si aggiungeva il fatto che coloro che lo producevano dedicavano meno tempo
alla sua produzione. Si arrivava così ad avere beni il cui prezzo in
termini temporali era aumentato dal fatto che coloro che producevano il bene
facevano la coda e non potevano dedicare tempo alla sua produzione che quindi
risultava più bassa, il che rendeva il bene meno reperibile e, in termini
di tempo, più costoso, seguendo un processo che non riusciva ad interrompersi.
Con la conseguenza che il tempo escluso da una parte rientrava dall’altro,
ovviamente il comportamento razionale del consumatore non poteva concettualmente
esistere.
>
>
[10] AA. VV., Complessità e biologia, Milano, 2002, p.59.
CARMELO PISASALE
Risposta di Chan Phap Y
May our mind be
A mind of deep listening and equanimity
May our mind be
A mind of understanding and sharing
May our mind be
A mind of compassion and love
Carissimi...
Lo sapevate che Thay è un esperto giardiniere? Lo sapevate che ha
veramente un pollice verde non solo nell’arte del seminare e del coltivare
ma anche nella difficile gestione della potatura?
Quando gli dirò, appena sarà rientrato dalla Germania e dalla
Scozia, che gli abbiamo ritrovato una sua antica delizia, sono certo ne
sarà felice. Come voi, come me.
Ho aperto una nuova finestra della mente verso questo grande, inaspettato
e insospettato viaggio dentro l’anima della mia terra. So bene che
ciò può trasformarsi in sofferenza per me (è già
accaduto due volte di recente), ma so altrettanto bene che solo toccando
la terra, la mia terra, posso iniziare un processo di riconciliazione e
di guarigione.E’ una storia lunga, una storia che non va raccontata,
già perduta nel tempo.Ma cosa è il tempo?
Apollonio di Tiana, che tanto amò la mia Isola, insegnava che il
tempo è immortale grazie alla memoria. Non disse però che
la memoria del tempo può anche divenire una sottile vena di dolore
. Mai comunque azzardò una ipotesi speculativa sulla natura del tempo,
non avrebbe potuto, né con la sua rutilante e personalissima logica
né con i suoi magamenti.
Il vecchio Apollonio, che al suo tempo fu il Cristo dell’altra sponda,
quella cosiddetta pagana, ci dice sottilmente che la memoria delle illusione
è matrice di sofferenze.
Come si puo’ interpretare ciò che non esiste? Come si può
penetrare nei canali di una relatività incompiuta quale la coscienza
umana, origine del concetto di tempo in quanto referenza di ogni fenomeno
manifestato nello spazio?
Il Dhammapada comincia così : Noi siamo ciò che pensiamo.
Se noi pensiamo di essere fatti anche di elemento tempo, il tempo esiste.
Ma dove e per chi? La catena di speculazione sarebbe infinita, fine a sé
stessa, speciosa. Ci rinuncio.
Mi difendo tuttavia dall’accettare che una categoria esistenziale del
pensiero esista come individualitá motrice autonoma.
Penso piuttosto che il concetto di tempo si dissolva nella consapevolezza
dell’interessere. Nella Rete di Indra ogni singolo nodo riflette
tutti gli altri, l’interconnessione è a un livello così
profondo che non è possibile differenziare un nodo dall’altro.
L’azione svolta nello spazio di un nodo è contemporanea a tutti
gli accadimenti negli spazi degli altri nodi. In tale armonioso espandersi
di immagini che sono e pur non sono ripetizioni speculari, l’inserimento
di una ipotesi chiamata tempo sarebbe non solo riduttivo ma assurdo.
Eppure trovo che il geniale autore dell’Avatamsaka Sutra, probabilmente
troppo soddisfatto della sua incorruttibile intuizione, ha perduto una gemma,
i nodi della rete sono gemme, lungo il cammino della sua meditazione: i
diamanti/nodi che riflettono tutti gli altri, riflettono anche se’stessi.
Siamo ai limiti dell’assoluto geometrico e speculativo, siamo all’astrazione
sublime, alla penetrazione totale negli undergrounds della coscienza (Alaya
Vijnana).
Quando cammino nella foresta di querce atrofizzate che fiancano la collina
mi sento una e una sola entità insieme agli alberi, ai tassi, ai
caprioli, ai merli e ai rossigoli serali, all’erbe mediche e a quelle
da fiore.Non percepisco alcuna dissociazione dell’essere, alcuna schizofrenia
cartesian-darwiniana. Io sono l’albero, io sono lo storno che vola,
io sono la piccola lucertola che guizza impaurita fra steli fitti di felce,
io sono il tempo perché l’idea di tempo è trasformata
dallo stato contemplativo.
Amo spesso pensare al tempo nella stessa maniera in cui penso allo Zen:
per negazioni. Lo Zen non è kimono, lo Zen non è cerimonia
del tè, lo Zen non è meditazione seduta, lo Zen non è
koan, lo Zen non è bruciare incensi, lo Zen non è inchinarsi
a tutto e a tutti, e così andando per i rami intricati del percorso
umano. Il tempo non è ieri, infatti ieri non esiste; il tempo non
è domani, infatti domani è solo un’idea, non esiste;
il tempo non è oggi, infatti “oggi” è solo una convenzione
linguistica per definire l’insieme di varie azioni o percezioni di
fenomeni nell’immediato raggio del nostro pensiero a cui diamo apparenza
di stabilità o immanenza.
Nello Zen Nirvana significa felicità senza restrizioni, una felicità
che deriva dall’acquisizione di una consapevolezza trascendente (prajna
paramita) di tutti i fenomeni. Questa consapevolezza non è fine a
sé stessa; innanzitutto è comprensione della sofferenza altrui,
è compassione, é amore ed equanimità. Quando noi diciamo
che lo stato di consapevolezza globale, nel Buddhismo tradizionale chiamata
bodhi, parola maltradotta con illuminazione o, peggio, con risveglio,
è qui e ora non intendiamo certamente circonscriverla nello spazio-qui-
né in una dimensione astratta di tempo –ora-.
Qui e ora significa consapevolezza che la mia percezione non è personale
ma universale giacché la persona che identifico con io è nient’altro
che la somma di componenti non-persona. L’idea di tempo ma anche l’idea
di spazio si rivelano illusorie.
Se noi siamo, e lo siamo davvero, l’assemblaggio di acqua, di minerali,
di vegetali, allora anche le montagne, il mare, le nuvole, la pioggia, e
tutti gli altri fenomeni nell’universo, inclusa l’orzata di Nino,
sono elementi essenziali di quel che chiamavamo avanti persona (pudgala)
oppure io/ego/ens. In siffatta complessità non c’è spazio
- in senso figurativo - per un concetto così deprimente come quello
di tempo.
Eppure tempo è l’utensile di misura della nostra stessa vita.
Ma è poi vero? Può l’homo faber vivere senza utensili?
Chiediamoci pittosto se l’ homo conscius, quello che sa ascoltare
profondamente e intuitivamente accedere alle radici dell’energia cosmica,
ha bisogno di illusioni. Poiché null’altro è il tempo
se non illusione, quella stessa illusione che noi calendizziamo nella dimensione
relativa della nostra esistenza. Nel buddhismo tradizionale si parla di
realtà storica o relativa e di realtà ultima. Le due espressioni
sono bavarderia gratuita perché sebbene solo la prima implichi una
dimensione spazio-temporale, anche la seconda è una illusione poiché
stimolando la mente a un percorso fuori dal qui e ora, per consequenza,
e paradossalmente, implica ció che vorrebbe negare: il tempo. Siamo
drammaticamente violentati dai limiti espressivi del nostro stesso linguaggio.
L’intuizione non ha parole, come trasmetterla?
A meno che noi accettiamo la teoria della particella primeva che esplode,
il Big Bang come ironicamente la definì Hoyle. L’esplosione
crea la materia che occupa, creandola con sua presenza, la dimensione spazio-temporale.
Una dimensione minima se è vero quel che Arthur Eddington, il più
filosofo fra i fisici del XX secolo, affermava , e cioè che la materia
nell’universo è una sorta di fantasma essendo lo spazio vuoto
per il 99,999999999%.
In The unreality of time (1908) Mc Taggart sostenne l’illusorietà
del tempo e dei suoi tempi consequenziali, F.H. Bradley non fu da meno nel
suo Appearance and Reality e molti altri filosofi aderirono apertamente
alla tesi della non-realtà mentre molti altri discretamente assentirono
ma senza troppo clamore. Lo Zen non era ancora arrivato in Europa sebbene
D.T. Suzuki ne stesse già tessendo la struttura teorica della propagazione.
Molto tempo fa, in un villaggio himalyano vicino all’Annapurna, uno
di quei giovani occidentali che vagabondano un po' dappertutto in cerca
della pietra filosofale della spiritualità mi chiese di condividere
come si risolve un koan. Gli risposi: trova la radice quadrata del
tempo. Il cercatore se ne andò alla scoperta di altri villaggi.
Alla fine della mia lettera tiro una pietra contro di me, si fa per dire,
e affermo che Zen é anche meditazione seduta, koan, qualche testo
e..... un giardino. Zen, come il tempo, è tutto e il contrario di
tutto. Mi restano seri dubbi sugli incensi, gli inchini e altri non ritualistici
riti. Nessun dubbio sulla inutilità dei kimoni. Come il tempo. Il
domani non esiste ma ho bisogno del domani per sognare e poetare.
Lo Zen? Il tempo? Un meraviglioso paradosso che apre la porta verso l’infinito.
Dal profondo della mia anima mediterranea, sicilianamente vostro con fraterno
amore
Chan Phap
Y
P.S. L’idea di tempo, il tempo come realtà labirintica
in cui si evolve la nostra vita quotidiana, il tempo come metro di progetti,
il tempo come arma di guerra, il tempo degli innamoramenti, il tempo delle
profonde meditazioni, il tempo come strumento di pace......e molti altri
temi. Tutti asimmetricamente sparsi nel grande mare della confusione esistenziale,
l’illusione generatrice di dolore. Entra la visione zen della vita
e...tutto cambia, tutto si trasforma.
Tanto materiale per una fabbrica in piena produttivitá...
Cari amici,
sorseggiamo l'orzata e gustiamoci l'intervento di Chan Phap Y.
Le cose belle: gli innamoramenti, l'incontro con un Maestro, con gli amici,
le iniziative creative accadono... Un po' come dall'incantesimo di Fata
Morgana, dal misterioso universo sorgiamo con le nostre storie e il nostro
tempo (seppur nostro) così altri interventi e quesiti sorgeranno.
Anche l'attesa della risposta, mai finale, la sua incubazione ha il suo
fascino. ciao
nino
Torna a GIARDINO ZEN ad Avola